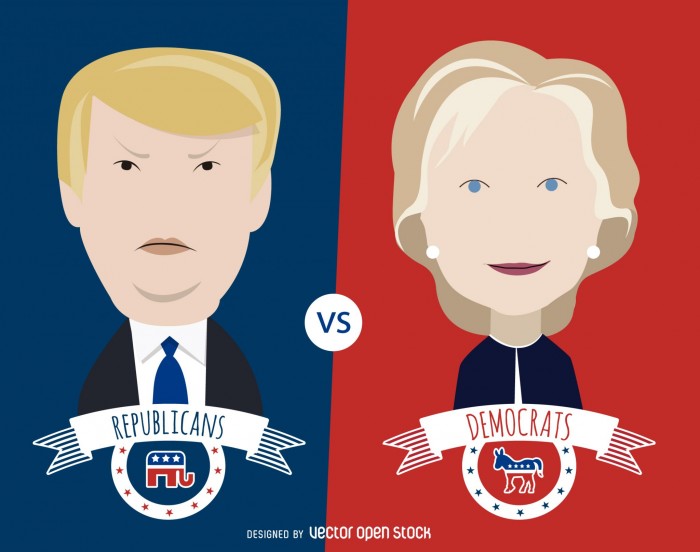Nel primo faccia a faccia per la Casa Bianca, la candidata democratica svetta sul tycoon repubblicano. Ma la corsa presidenziale resta apertissima. Diamo un’occhiata alla retorica del loro primo confronto pubblico.
Expertus metuit: ovvero “colui che ha esperienza teme”, recita un proverbio latino ispirato ad Orazio. Potrebbe essere questa la morale da stilare a proposito del primo dibattito presidenziale del 26 Settembre, che ha visto una navigata Hillary Clinton approfittare per 90 minuti della totale mancanza di preparazione di Donald Trump, fino a sfruttare la rinomata self-confidence del suo avversario per ritorcergliela contro con una maestria da manuale, in favore di telecamera.
Solo in tal modo è possibile spiegare le ragioni di una performance tanto sconnessa, volubile nei toni ed ondivaga negli argomenti, da parte del candidato repubblicano: il sospetto è che Trump abbia deliberatamente evitato qualsiasi forma di briefing prima del confronto pubblico, fiducioso che la forza della sua spontanea verve polemica avrebbe costretto naturalmente la Clinton a riparare sulla difensiva. Ma lei, probabilmente aspettandosi il peggio, è riuscita a parare tutti i colpi con la facilità che appartiene solo a chi si è allenato con attenzione meticolosa per rispedire ogni accusa al mittente, per controbattere ad ogni invettiva facendo appello ad un’opposta evidenza dei fatti, per assestare la punchline più opportuna ad ogni occasione in cui Trump avesse lasciato un fianco scoperto.
Al termine del confronto tenutosi sul palco della Hofstra University di New York, seguito da un’audience televisiva di 100 milioni di americani, un engagement sui social misurato in 18,6 milioni di partecipanti su Facebook ed un volume di 6,7 milioni di tweet, il cinguettio più condiviso appartiene ad un conduttore di talk show noto ma non celebre fuori dagli States, Jerry Springer: “Il posto di Hillary è alla Casa Bianca, quello di Donald Trump è come ospite al mio show!”. Al di là dei sondaggi di opinione, il sipario per il momento è calato mentre proprio in questa frase è riposta la sostanza nuda e cruda di quel che è andato in onda: Donald Trump ha fatto una figuraccia, senza riuscire a trasmettere un briciolo di autorevolezza. Ma per la Clinton è stata una vittoria? Questa è una questione più complicata, per diverse ragioni.
Meglio parlare al cuore
In un volume che è ormai un classico della comunicazione elettorale, “La mente politica” di Drew Westen, l’autore – consulente politico e docente di psicologia alla Emory University – individua nell’incapacità di costruire una connessione emotiva con il pubblico atteso alle urne la grande debolezza dei candidati democratici che storicamente si sono susseguiti nella corsa alla Casa Bianca.
Le eccezioni come Bill Clinton, JF Kennedy e Barack Obama hanno avuto successo nel loro intento perché sono riusciti a fare riferimento alle attese, alle speranze, e più in generale a toccare i valori e le emozioni dell’americano medio rimpiazzando il lessico liberal da professori e professionisti della politica con un registro relatable, familiare e alla mano. Soprattutto, sono riusciti a costruire immagini fortemente evocative per trasmettere le proprie idee all’elettorato, comprendendole in uno storytelling coinvolgente ed intriso di emotività.
Per Westen, come per molti studiosi, la maggior parte dell’elettorato è già affiliata in modo irremovibile con l’uno o l’altro schieramento, ed è difficile che scavalchino il recinto per passare ad una collocazione politica ideologicamente distante dalla propria: ogni elezione si gioca sulla fetta minoritaria di indecisi con le idee poco chiare, che votano per il candidato e non per il partito. Piuttosto che snocciolare valutazioni cerebrali e statistiche ponderate sui propri programmi, per convincere questo settore di elettori è necessario agganciarli sviluppando una percezione emotivamente gradevole: al fine di smuovere indecisi e potenziali astenuti sarà vano promettere loro vantaggi pratici senza prima essere stati “accettati” come portatori per lo meno di ispirazione o di rassicurazione.
L’analisi di Westen è categorica: nessun candidato democratico ha mai vinto arrivando alla testa ma senza arrivare prima al cuore degli americani. Hillary, dotata di un profilo politico competente ma di vecchio stampo, si presenta dunque come una candidata in affanno. Il rischio è di mostrare una simpatia artefatta, un approccio da statista convincente ma arido o, peggio ancora, uno snobismo venato di condiscendenza.
Con un candidato politicamente sprovveduto, culturalmente scorretto, reazionario ed oserei dire storicamente pericoloso come Trump e dall’altro lato un’antagonista priva di una popolarità diffusa e trasversale come Hillary, il dilemma degli americani sembra essere stato ben espresso dall’analista politica Amy Walter: “Queste elezioni saranno ricordate come un referendum su chi è il peggior candidato”.
C’è da credere ragionevolmente che le previsioni sul prossimo presidente degli Stati Uniti, a scanso di sviluppi inattesi e devastanti per la comunicazione dell’uno o dell’altra, rimarranno attaccate ad un filo fino a Novembre. Come inquadrare dunque l’output del dibattito di questa settimana?
Before and after the #PresidentialDebate: searches by US state for @HillaryClinton & @realDonaldTrumphttps://t.co/c3Eqtco5Je pic.twitter.com/Ekt9E3d13B
— GoogleTrends (@GoogleTrends) September 27, 2016
Ignorare il brand di Donald
Hillary non ha le elezioni in tasca, ma i suoi spin doctors hanno avuto astuzia da vendere, e la sua performance è stata impeccabile. Sfoggiando un sorriso non sardonico e almeno apparentemente genuino, dopo essere stata introdotta dall’anchorman Lester Holt, la Clinton si è avvicinata a Trump tendendogli la mano. “Hey! How are you Donald?”: il saluto detterà il tono dell’ex first Lady per tutto il dibattito. Rilassata ma seria, riesce a comunicare entusiasmo per le proprie idee senza “fare la lezione” sugli argomenti trattati, che spaziano dall’occupazione, all’ambiente, alla politica estera, alle sfide della globalizzazione per l’economia americana.
E quel “Donald”, sempre ripetuto per tutta la serata rivolgendosi all’avversario – il presentatore lo chiamerà più formalmente “Mister Trump” – è strategicamente mirato ad innervosirlo. Trump le chiede, per la durata del confronto, se lei acconsenta che lui le si rivolga come “Secretary Clinton”, molto più rispettosamente di quel “Crooked Hillary” (“quella corrotta di Hillary”) con cui tuona cinguettando dal suo account Twitter: un atto di ipocrita galanteria volto a metterla in ridicolo, ma lei non sembra suscettibile alla provocazione.
A perdere la calma è invece lui, minuto dopo minuto, quando si rende conto che lei lo ha chiamato “Donald”, e solo “Donald”, da più di 10 minuti. Ad essere eclissato è il brand Trump, lo stendardo del suo potere, il marchio del trionfo imprenditoriale che lui desidera imprimere nella mente dei telespettatori, convincendoli della sua capacità di trasferire la grandezza dei suoi affari nella futura grandezza della nazione (“Make America great again” è il suo slogan).
Quando Hillary utilizza la parola “Trump” lo fa in modo caricaturale: definendo la sua idea di neoliberismo (comunemente nota agli economisti come “trickle-down economics” di thatcheriana e reaganiana memoria) come “Trumped-up trickle down economics”, una versione estrema ed aggravata dell’originale, la Clinton lo canzona in modo inatteso e bruciante (il phrasal verb “to trump something up” in inglese significa “inventare qualcosa di falso”).
Hillary definisce il piano di tasse proposto dall’avversario come un “Trump loophole”, perché favorirebbe in modo spropositato le aziende di sua proprietà. Il repubblicano si rende conto del sottotesto, ed ogni “Donald” pronunciato da Hillary quando gli dà del tu inizia a pesare come un insulto esplicito.
Colpito e…affondato?
Dopo mezz’ora di dibattito, ogni sforzo per mantenere un contegno apparentemente presidenziale è sparito: Trump gesticola istericamente, interrompe risentito sia Hillary che il moderatore, urla costantemente (mentre Hillary mantiene un tono di voce colloquiale), e soprattutto inizia a tergiversare in boriose giustificazioni ad ogni frecciata che la Clinton gli rivolge in modo sapiente e pungente sul suo sessismo, sul suo razzismo, sulla sua incompatibilità temperamentale rispetto al ruolo di presidente.
Convinto inizialmente di giocare all’attacco, giocherà fino alla fine sulla difensiva. I tentativi di mettere dialetticamente in cattiva luce la Clinton si trasformano in un ripetuto dito puntato, l’esposizione dei suoi progetti politici – dopo i primi venti minuti in cui spiega i suoi piani per l’economia americana in modo generico, ma chiaro e conciso – inizia presto a perdersi in farneticazioni risibili. Non stiamo più guardando il palco di un candidato presidenziale, ma il confessionale del partecipante ad un reality-show.
La Clinton, dal canto suo, sorride smagliante, mentre Trump abbocca ad ogni esca con una risposta inaccettabile: quando lei lo accusa di aver trovato scappatoie per evadere le tasse federali lui non nega affatto, e risponde stizzito “That makes me smart”; quando lei lo attacca per aver sottopagato i suoi lavoratori risponde che “ha approfittato della legge che glielo permetteva”, e che “forse non meritavano di essere pagati”; dopo che lei gli rinfaccia di essersi dichiarato felice della crisi perché gli ha aperto nuove opportunità speculative, lui ribatte “That’s called business”. Talvolta sembra che da un momento all’altro voglia farle il verso.
Quando lui decide di alludere ai problemi di salute di lei, la accusa di essere rimasta a casa negli ultimi giorni, mentre lui girava l’America per la sua campagna elettorale. Lei risponde: “Penso che Donald mi abbia appena criticata per essermi preparata a questo dibattito. E ammetto, l’ho fatto. Sapete per cosa altro mi sono preparata? Mi sono preparata per essere presidente”. Finita la trasmissione, i media massacrano Trump. E la battuta di Jerry Springer da 300mila like su Twitter appare abbastanza ovvia: da una parte c’era una candidata presidenziale, e dall’altra un bifolco con una retorica da osteria.
Day after debate, Clinton gloats and Trump fumes https://t.co/pHLbEw6wL9 https://t.co/QXOJ0IBQHc
— Anderson Cooper 360° (@AC360) September 28, 2016
La retorica va esercitata in anticipo
Il suo team tenta di correre ai ripari ma l’idea è manifesta: Trump è stato così incosciente da non prepararsi con delle simulazioni. Alla giornalista Katie Pavlich la portavoce del candidato repubblicano Sarah Huckabee risponde che “lui non è un robot testato e ammaestrato con un copione, come Hillary. Lui fa ciò che è meglio considerata la sua natura spontanea, che è essere se stesso e nel caso improvvisare. Questa è la grande differenza tra i due, che penso sia stata interessante per gli spettatori stasera”. Un modo diplomatico per smarcarsi da una performance disastrosa. Che in ogni caso non gli costerà cara: anche se nei sondaggi la Clinton ha guadagnato un paio di punti percentuali, Trump è riuscito negli ultimi mesi ad appianare un distacco di dieci punti.
La candidata democratica, dal canto suo, è apparsa più umana, trasmettendo una percezione di sé più saggia ed equilibrata che la favorirà con l’elettorato femminile: sicuramente da lei non ci si poteva aspettare di meglio. Menzionando i valori di suo padre, un uomo di origini umili ma che riuscì a creare un fiorente small business nell’ambito tessile, Hillary non avrà costruito una storia personale particolarmente coinvolgente per il pubblico, ma ha saputo in ogni caso riavvicinarlo a sé, ed è riuscita a non porsi come un membro della élite di Stato distante dal cittadino comune.
Non avendo permesso a Trump di tenere le redini della discussione in qualità di “inquisitore” degli sbagli commessi in trent’anni di carriera politica, il dibattito di Hillary può definirsi un successo. Sarà determinante per la sua vittoria tenere insieme l’elettorato del partito grazie alle campagne che Bernie Sanders e gli Obama porteranno avanti nel prossimo mese.
In una partita per la Casa Bianca finora giocata alla pari, Hillary Clinton è riuscita a rappresentare davanti agli americani la disparità che la separa da Donald Trump e ad elevare la percezione della sua candidatura, senza inciampare in incidenti di presunzione. Si tratta di una disparità sia culturale che attitudinale, un dislivello di preparazione e di prospettive che riesce a caratterizzarla come una figura presidenziale credibile.
Di sicuro, Trump tornerà al prossimo dibattito più agguerrito, e forse preparato. Dopotutto, sbagliare due volte in guerra non è concesso: bis peccare in bello non licet.
Pierluigi Schiano Moriello su Comunicatore Pubblico (Fb: Comunicatore Pubblico)