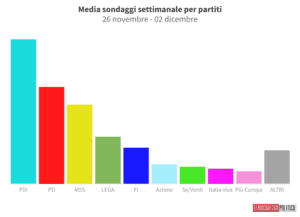Dossier: la legge e il fine vita

Due ipotesi di incostituzionalità
[ad]Si ricordi anzitutto che in Italia il fondamento costituzionale del diritto all’autodeterminazione terapeutica è rinvenibile nella parte prima della nostra Carta, quella relativa ai diritti e ai doveri del cittadino e, più specificatamente, nell’art. 32 Cost. che sancisce il diritto alla salute. Analizzando gli atti dell’Assemblea Costituente sembra infatti potersi individuare nell’art. 32 il principio cardine della “volontarietà” dei trattamenti sanitari in cui, a ben vedere, si rinviene un riferimento all’intero sistema di valori che hanno ispirato la redazione della Carta Costituzionale: il principio personalista, il principio dell’inviolabilità della libertà personale, il principio del rispetto della dignità umana. Non a caso, la Commissione per la Costituzione aveva approvato, nella seduta plenaria del 28 gennaio 1947, con un intervento di Aldo Moro, una formula dell’articolo che si riferiva espressamente al concetto di “dignità umana”. Solo successivamente, in sede di dibattito in aula, Giuseppe Caronia, appoggiato da Giovanni Leone, propose un emendamento che sostituiva alla parola “dignità” quella di “personalità” e che, infine, veniva approvato nella seduta del 24 aprile 1947. Si tratta del fondamentale principio personalista che, richiamato in maniera univoca nell’art. 1, comma 2 e nell’art. 2 della Costituzione, da un lato orienta l’assetto del rapporto istituzionale tra persona e Stato successivo al fascismo, in modo tale da riconoscere al secondo una funzione strumentale rispetto al primo; e dall’altro impone che la realizzazione del principio democratico, quale “ordine complessivo della vita associata”, debba riconoscere e garantire la sfera di libertà indispensabile alla piena espressione della persona. Da ciò se ne desume che il ddl in esame, sancendo che il NIA non possa formare oggetto di DAT, importa una violazione dell’art. 32 della Costituzione: la Corte di Cassazione, nella sua decisione sul caso Englaro, ha infatti definito il diritto al rifiuto di trattamenti anche salvavita come risvolto negativo di un diritto di libertà che “non può essere scambiato per un ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”. Allo stesso modo, è da ritenere che il richiamo al bene indisponibile e inviolabile della vita non possa valere sino al punto di sacrificare l’altro fondamentale diritto alla libertà di cura del paziente: “la salute dell’individuo non [può] essere oggetto di imposizione autoritativo – coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio […] per una strategia della persuasione […]; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico”.
Il secondo dubbio di costituzionalità che si può formulare con riguardo al disposto di cui al comma 5 dell’articolo 3 del ddl 2350 è quello che riguarda il rispetto del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Infatti, onorando quanto statuito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, il legislatore forse dovrebbe permettere al soggetto incapace, attraverso la ricostruzione della sua volontà, in primo luogo con l’ausilio della DAT, di autodeterminarsi in campo sanitario allo stesso modo in cui tale possibilità è riconosciuta al soggetto capace che può esercitare un consenso attuale e informato all’atto medico. Che la diversa situazione in cui versa la persona incapace non deve giustificare un approccio diverso nei suoi confronti nei termini del rispetto della sua autonoma volontà in ambito sanitario, è stato anche riconosciuto da una recentissima sentenza del TAR del Lazio secondo cui “i pazienti in stato vegetativo permanente che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti”. Inoltre, lo stesso Tribunale ha evidenziato che, trattandosi di un diritto di rango costituzionale quale quello della libertà personale inviolabile ex art. 13 Cost., il paziente in stato vegetativo permanente (SVP) “vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli steso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi”.
(per continuare la lettura cliccare su “5”)