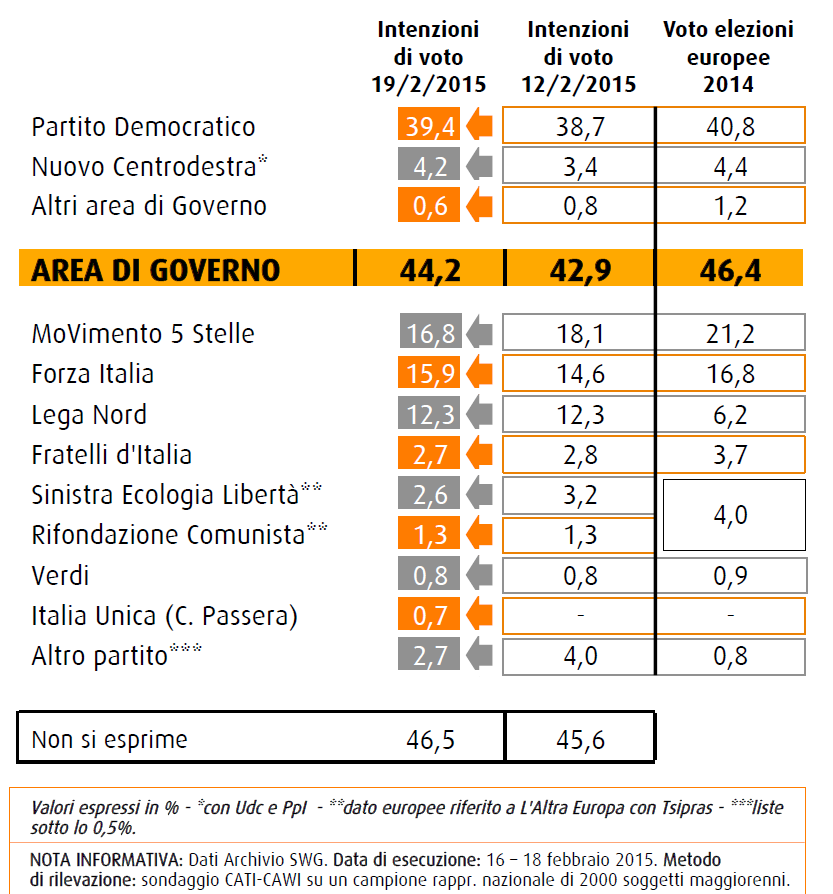È il 6 febbraio 2015, e a New York fa ancora più freddo del solito. La già non certo tiepida costa atlantica è stata investita da un freddo letteralmente polare, che ha fatto precipitare le temperature vicino ai 20 gradi sotto zero. Chiuso in una stanza del NYU Langone Medical Center di Manhattan, coi doppi vetri a tentare di tenere il gelo al di fuori, c’è un gigante dalla pelle di ebano. Il suo cuore ha subito un pesantissimo attacco e in quel momento sta lottando tra la vita e la morte. C’è abituato, a combattere. È il suo modo di essere, il suo stile di vita. Lo ha fatto da sempre, fin da quando si è presentato al mondo il 14 dicembre del 1966. Ha combattuto nello sport e nella vita. In campo e fuori dal campo. Con gli avversari ma anche con gli amici. A volte pure contro i mulini a vento, e probabilmente un po’ anche contro se stesso. Quel gigante si chiama Anthony George Douglas Mason, ma in città -la città per eccellenza- per tutti è semplicemente “Mase”.
Un inizio difficile
Estate 1988. “Con la scelta numero 58 del terzo giro i Portland Trail Blazers scelgono Anthony Mason.”
Altro pianeta, il 1988, in tutti i sensi. In NBA le squadre sono 25, cinque in meno di oggi, e i giri di scelta dei giovani in uscita dal college sono tre. Uno in più di quelli attuali. Uscito dalla cestisticamente modesta Tennessee State con 28 punti e 10,4 rimbalzi nel suo anno da senior, Mason non gode sostanzialmente di nessuna considerazione. College troppo piccolo, con avversari troppo deboli perché quelle cifre mirabolanti possano avere diritto di cittadinanza al piano di sopra, anche se non esiste una scienza più inesatta (e un mestiere più ingrato) di quello di scegliere in un draft NBA. Nello stesso anno, per dire, finiscono senza nemmeno essere chiamati personaggi come Avery Johnson e John Starks. Portland non dà al lungo (2.01 per 110 chili) nemmeno una chance e lui finisce a giocare coi turchi dell’Efes Pilsen. Dopo una stagione passata oltreoceano riprova la carta della NBA, firmando con i Nets e giocando con loro 21 partite a 1,8 punti e 1,6 rimbalzi di media. Briciole, se proprio vogliamo essere onesti. Bisogna lottare ancora per trovare spazio, ma prima ancora semplicemente per sopravvivere. Le tre partite con Denver nella stagione 90-91 non bastano a sbarcare il lunario, e così arrivano in ordine sparso la lega Venezuelana e la CBA che ai tempi, prima di fallire, era in sostanza la prima lega minore americana. Sarebbero, per la cronaca, 29,9 punti e 14,8 rimbalzi di media al termine della stagione. Numeri di tutto rispetto che valgono non una, ma LA chiamata. Sì perché se sei cresciuto nella Grande Mela (pur essendo nato a Miami), quando all’altro capo della cornetta -altri tempi, ve l’ho detto- ci sono quelli dei Knicks, anche solo per un invito al training camp senza certezze di ottenere un contratto, ci sono poche cose che nella vita ti possono rendere più orgoglioso e felice.
Pat Riley
Ogni guerriero che si rispetti ha legato a se un maestro, un mentore o almeno una figura di riferimento che lo renda consapevole dei suoi mezzi e ne forgi, ne sviluppi e ne incanali la forza. Quella figura per Mason non può che essere il coach di New York di quel periodo nonché uno dei più grandi allenatori della storia del gioco: Pat Riley. Pat sta cercando di riportare i bluarancio a grandi livelli attraverso un gioco duro, fisico e per certi versi simile a quello dei Bad Boys di Detroit. Quando mette gli occhi su questo ragazzo mancino, col fisico d’acciaio ma dai piedi veloci e una mano educata, non crede ai propri occhi. La firma arriva immediata e Mason, partendo dalla panchina, va a formare un quartetto col quale anche una gita notturna per le vie del Bronx apparirebbe come una passeggiata di salute. Ci sono lui, Charles Oakley, la stella Pat Ewing e John Starks. Si, lo stesso che in quel draft di cui sopra nessuno aveva nemmeno considerato. Il New York Times lo definisce “a muscolar, bellicose forward”, e a parte l’ultimo termine che sta ad indicare il suo ruolo in campo, direi che non necessita di altre traduzioni. La squadra scala rapidamente le classifiche della durissima Eastern Conference, battagliando spesso ad armi pari ma uscendone sempre sconfitta coi Bulls di sua maestà Michael Jordan. Sono cinque anni favolosi per Mase, che culminano con la finale raggiunta nel 1994 (con Jordan a dedicarsi al baseball per un anno e mezzo) e persa in sette gare contro Houston, e col premio di miglior sesto uomo dell’anno nella stagione successiva. Sono anni di grandi successi con una città a idolatrare i suoi beniamini, ma sono anche anni di scontri col suo mentore Riley in campo e di indisciplina al di fuori. Problemi frequenti con la polizia e liti col coach per avere più spazio e magari un ruolo da titolare. In sostanza una lotta continua.
La carriera
A fine 95 Riley se ne va a Miami e il suo successore Don Nelson lo promuove in quintetto ricevendo in cambio i massimi in carriera in punti (14,6) rimbalzi (9,3) e assist (4,4). Senza la sua vera guida però, Mase finisce decisamente troppo fuori controllo, e così la dirigenza stanca dei suoi comportamenti lo spedisce a Charlotte in cambio di Larry Johnson, attaccante migliore ma difensore anni luce più scarso di lui. Agli Hornets resta quattro anni (saltando interamente il terzo per un brutto infortunio), ritoccando ancora i suoi primati alla prima stagione con loro e meritandosi l’inclusione nel secondo quintetto difensivo e nel terzo miglior quintetto assoluto. Nel 2000 il suo maestro lo richiama a Miami per completare una squadra con potenziale da titolo. Il problema ai reni di Alonzo Mourning abbatte ogni velleità in questo senso, ma Mason non fa comunque mancare il suo apporto, tanto da meritare addirittura la sua prima e unica convocazione per l’all star game e contribuendo a centrare comunque una sorprendente stagione da 50 vittorie. Giocherà ancora un paio d’anni a Milwaukee prima di ritirarsi definitivamente dopo tredici stagioni e 882 partite. Per uno che nessuno voleva decisamente non male.
Gli ultimi momenti
C’è un salto di quasi dodici anni dall’ultima partita giocata a quella calda stanza di ospedale di febbraio. In mezzo quattro figli, una femmina e tre maschi di cui uno visto anche a Cholet in Francia e un altro impegnato all’Università di Auburn, ma soprattutto l’emergere di problemi cardiaci culminati col tremendo attacco di oggi. La battaglia di Mase dura ventidue giorni, tra operazioni, medicine e deboli speranze di ripresa. Alla fine, quando anche con la sua inossidabile tenacia ha capito che le speranze erano terminate, ha chiesto di poter incontrare la persona che gli ha cambiato la vita, che gli ha regalato la possibilità di dimostrare quanto potesse valere davvero come giocatore e che gli ha permesso di diventare quel che è diventato. Perché, sono parole sue, “Pat Riley è stato quello che mi ha dato la mia occasione. È quello che ha visto qualcosa in me che nessun altro aveva visto.”
Raccontano che una volta Riley, per motivare quei suoi Knicks prima di una gara importante, si presentò con un barile pieno d’acqua al discorso pre partita in spogliatoio. Guardò tutti i presenti e poi dichiarò “dovete giocare fino all’ultimo respiro”. Poi ficcò la testa nell’acqua e ce la tenne per un tempo interminabile. Quando qualcuno stava già iniziando a preoccuparsi per davvero la tirò fuori ed esclamò “Fino all’ultimo respiro!”. I suoi uscirono dallo spogliatoio come belve. Chissà invece cosa si saranno detti in quel loro ultimo incontro. A me piace immaginare che abbiano scherzato parlando di basket e ricordando i vecchi tempi, le litigate tipiche di due caratteri tanto forti quanto simili e perché no, si siano detti addio con un lungo abbraccio come sanno fare solo i veri uomini, i veri amici e i veri guerrieri. Pochi infatti sono entrati nel cuore dei tifosi tra i più esigenti d’America come il guerriero con il numero 14. Pochissimi hanno combattuto più di Mason, trasformando ogni gara in una battaglia vera e portando anche il più ostico dei nemici, cioè un cuore letteralmente a pezzi, a dover attendere ventidue giorni prima di poter avere la meglio su di lui. Come avrebbe detto Riley.. Fino all’ultimo respiro.