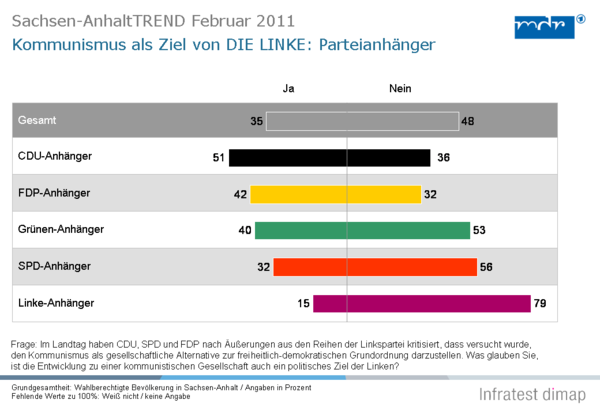Il 23 giugno 2016 il Regno Unito ha scelto di lasciare l’Unione europea. La Brexit è diventata realtà con un margine risicato: il 51,89% dei votanti ha scelto il ‘leave’, contro il 48,11% di remainers. L’affluenza (72,2%) ha superato quella delle precedenti elezioni generali del 2015 (66,1%). Era un referendum consultivo e perciò, di fatto, non vincolante. Tuttavia, avrebbe segnato il dibattito politico del paese per i successivi tre anni e mezzo, fino al definitivo divorzio dall’UE il 31 gennaio 2020.
Secondo un sondaggio realizzato da Lord Ashcroft, su un campione di oltre 12 mila persone, i giovani hanno votato soprattutto per il ‘remain’, in particolare il 73% degli elettori di età compresa tra i 18 e i 24 anni, e il 62% della fascia 25-34. La maggioranza degli over 45, insieme al 60% degli over 65, hanno optato per l’uscita. Hanno scelto di lasciare l’Unione anche la maggioranza dei disoccupati e dei pensionati, mentre il 57% dei laureati, così come l’81% degli studenti, ha votato per rimanere.
Il ‘leave’ ha avuto la meglio in nove regioni: South East, North West, East, South West, West Midlands, Yorkshire, East Midlands, Galles e North East. Solamente a Londra, in Scozia e nell’Irlanda del Nord la maggioranza dei votanti ha optato per restare nell’UE, oltre alla quasi schiacciante vittoria del ‘remain’ (95,9%) a Gibilterra.
La campagna elettorale
Tra gli schierati per il ‘remain’ figuravano il Partito Laburista guidato da Jeremy Corbyn, il Partito Nazionale Scozzese, e i Verdi. Dichiaratamente nella fazione opposta, invece, erano il Partito Unionista Democratico e l’UKIP, il Partito per l’Indipendenza del Regno Unito guidato da Nigel Farage, uno dei volti più rappresentativi della campagna per il ‘leave’. Il Partito Conservatore, allora al governo, non ha preso una posizione ufficiale: il premier e leader del Partito David Cameron invitò la popolazione a votare per restare, ma tra i conservatori c’erano nomi altisonanti che spingevano nella direzione opposta: la presa di posizione pro-Brexit di Boris Johnson e Michael Gove diede una spinta decisiva ai leavers.
Il dibattito tra ‘leave’ e ‘remain’ è stato acceso e agguerrito, e il tema dell’immigrazione ha giocato un ruolo determinante. Da tempo Cameron aveva promesso di ridurre i flussi migratori, che preoccupavano l’opinione pubblica inglese soprattutto da quando l’Europa si era espansa a est, nel 2004 e nel 2007. La Brexit, secondo i suoi sostenitori, avrebbe restituito al Regno Unito non solo il controllo sull’immigrazione, ma anche l’indipendenza economica e la sovranità.
L’altro grande terreno di scontro era figlio dell’epoca: la lotta tra le élite e il popolo, che proprio in quei mesi stava segnando la crescita nei sondaggi dei partiti populisti europei e di Donald Trump negli Stati Uniti. Non a caso, i leavers dipinsero l’Europa e Bruxelles come “l’establishment”, una classe di privilegiati lontana dal popolo inglese.

Nessuna delle due fazioni venne risparmiata da accuse di fake news e manipolazioni. Fu una campagna costellata da scandali ed elementi divisivi, tre dei quali sono particolarmente degni di menzione, in ordine sparso. Il primo è la controversa figura di Dominic Cummings, lo stratega politico direttore della campagna Vote Leave, oggi consigliere del primo ministro Boris Johnson. Sarebbe lui la mente dietro al discusso messaggio sugli autobus, subito additato come falso, in cui si prometteva che senza l’UE il sistema sanitario inglese avrebbe avuto 350 milioni di sterline in più a settimana. La battaglia di Cummings per portare il Paese fuori dall’UE è stata raccontata nel film ‘Brexit: The Uncivil War’, con Benedict Cumberbatch nei panni dell’eminenza grigia.
Il secondo elemento della discordia è stato lo scandalo sul ruolo giocato dalla società di consulenza britannica Cambridge Analytica, più tardi accusata di aver influenzato il voto degli elettori sfruttando raffinate tecniche di manipolazione dei dati. Ci fu, infine, un terzo elemento che scosse il Paese, tanto da portare alla sospensione della campagna referendaria: il 16 giugno 2016 la deputata laburista Jo Cox fu uccisa in un villaggio vicino a Leeds da un nazionalista filonazista, che la accoltellò al grido di “Britain first”.

Come si è arrivati al referendum
L’euroscetticismo è sempre stato di casa nel Regno Unito, fin da quanto il paese è entrato a far parte del della Comunità Economica Europea (CEE) il 1° gennaio 1973. È stato presente, ma latente, per più di quarant’anni, fino a diventare impossibile da ignorare.
Il termine ‘Brexit’, un neologismo composto dalle parole Britain ed exit, venne usato per la prima volta nel 2012. Nello stesso anno sono cominciati i problemi per il premier di allora, il Conservatore David Cameron, in carica dal 2010 al 2016. Oltre alle pressioni dall’esterno, si facevano più insistenti le voci delle correnti euroscettiche del suo stesso partito. Nel luglio del 2012 cento conservatori firmarono una lettera in cui chiedevano il referendum sull’uscita dall’Unione, e il premier dovette stare ad ascoltare.
Nel gennaio del 2013 David Cameron disse che nuovi termini di adesione all’UE sarebbero stati negoziati e sottoposti agli elettori con un referendum entro la fine del 2017. Il premier voleva ottenere da Bruxelles controlli più stretti sull’immigrazione, più potere al parlamento nazionale e una riduzione dell’influenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul sistema giuridico inglese.
Nel febbraio del 2016 i 27 stati membri firmarono i nuovi termini di David Cameron, che nel tempo erano stati discussi e rimodulati, e il 20 febbraio fu annunciata la data del referendum, il 23 giugno di quello stesso anno. «Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?» sarebbe stato il testo del quesito referendario. Il 13 luglio del 2016, ammettendo la sconfitta, David Cameron rassegnò le dimissioni.