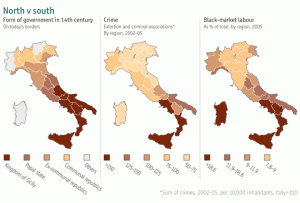Economist: pagella di un’Italia “fottuta”
Il ritratto del settimanale inglese sull’Italia del dopo (?) Berlusconi: schiava del suo passato o capace di cambiare? L’analisi di TP

“L’uomo che ha fottuto un intero paese”: piuttosto che soffermarci sulla provocazione di questo titolo di copertina dell’Economist, varrebbe la pena analizzare per bene i contenuti del report di 15 pagine sull’Italia e chiederci se rispecchino veramente il nostro paese e se ne condividiamo le soluzioni proposte.
[ad]Davanti ad un titolo talmente provocatorio è facile dimenticarsi che la serie d’articoli che annuncia, pubblicati una settimana fa dal settimanale inglese, rappresenta forse l’analisi più letta e sentita del nostro paese da parte d’intere classi imprenditoriali e politiche straniere.
Il problema di fondo dell’Italia è, a detta de l’Economist, una profonda malaise economica. Non importa se abbiamo sofferto poco la crisi o se la disoccupazione, al 8%, rimane al di sotto della media europea. Dati segmentati raccontano che alcune aree del Meridione hanno picchi di disoccupazione giovanile del 40%. Gli ultimi dieci anni hanno visto una crescita annuale media del PIL di 0.25%, superiore solo a quelle dello Zimbabwe e di Haiti.
Ma anziché chiederci se questa stagnazione economica è, come sostiene l’Economist, la più grande colpa di Berlusconi oppure, come nota Roberto Perotti de Il Sole 24 un secondo atto della scarsa crescita durante i governi di centro-sinistra degli anni 90, guardiamone le cause profonde.
L’Economist, citando esplicitamente il discorso d’addio di Mario Draghi alla Banca d’Italia, punta il faro su vari fattori:
- Scarsa produttività: La produttività del lavoro è cresciuta dello 0.1% annuo tra 2001 e 2005 e dello 0.8% tra 2006 e 2009. Questi dati, tra i peggiori nell’OCSE, sarebbero aggravati da un regime fiscale dagli incentivi perversi; dalla persistente sopravvivenza di aziende troppo piccole, spesso a gestione famigliare, le quali sono statisticamente più inclini all’inefficienza; dalla scarsa diffusione di transazioni elettroniche di denaro.
- Istruzione: C’è tanto di buono nelle nostre scuole primarie e secondarie. Le nostre università invece, eccetto poche private, non competono a livello mondiale. Questo priva il paese di prezioso capitale umano e contribuisce indirettamente all’imperversare delle raccomandazioni. Infatti, l’obbligatorietà di considerare equivalenti tra di loro titoli di studio da ogni università e la mancanza di test standardizzati rendono impossibile alle aziende valutare in maniera obiettiva un potenziale impiegato.
- Apparato giuridico: La lentezza della giustizia italiana è un forte disincentivo per chi investe. La bassa posizione dell’Italia nella classifica di competitività della Banca Mondiale (74esima) è dovuta almeno in parte a questo. In particolare ne sarebbe una causa la norma che prevede la possibilità di mandare in appello qualsiasi fase di un processo. Ciò fa si che in media una disputa contrattuale impieghi ben 1,210 giorni per essere risolta.
L’Economist menziona poi altri elementi del discorso di Draghi – distorsioni del mercato del lavoro, mancanza di competizione – per porre poi l’accento su conflitto d’interesse e ordini professionali.
- Conflitto d’interesse: Su questo l’Economist è attento a far notare che Berlusconi rappresenta solo un sintomo del problema piuttosto che esserne una causa. Sono citati colossi mediatici come il Corriere della Sera, di proprietà di Mediobanca, e il finanziamento statale dei partiti. Dal lato imprenditoriale di questa problematica, sarebbero controproducenti alcune regole particolari della finanza italiana. Quanto al conflitto d’interessi in campo politico, è chiaro che l’attuale legge elettorale non aiuta. Ma la causa sarebbe anche culturale. Per l’Economist la gerontocratica società italiana è “profondamente antimeritocratica” e vittima di un “familismo amorale”.
- Ordini professionali: Qui sono citati i classici esempi: taxi, farmacie e tv. Sarebbe valsa la pena forse parlare di più di altri ordini quali i notai, i cui costi sull’economia sono probabilmente molto più alti. Anche qui l’Economist da un lato offre una spiegazione legislativa, ovvero le norme che proteggono le varie categorie, e un’altra di natura storica, l’eredità degli ordini rinascimentali.
Fin qui niente di nuovo. I problemi li conoscevamo. Certo, potrebbe sorprendere anche il lettore italiano liberale sentire parole spese a favore di alcuni aspetti della riforma Gelmini oppure della Legge Biagi. L’Economist sostiene addirittura alcune parti della riforma della giustizia proposta dal centrodestra, in particolare la separazione delle carriere. La scarsa attenzione data ad altre questioni quali quella demografica e il debito pubblico potrebbe essere notevole se non fossero in fondo risolvibili con una più veloce crescita economica.
(per continuare la lettura cliccare su “2”)
Eppure se l’Economist è, come prevedibile, pro riforme, non è affatto scontato che riformare sia possibile né che sia una panacea per i nostri mali.
[ad]Offre infatti poche soluzioni concrete e ancor meno distinguo tra quali siano politicamente attuabili e quali invece no. Quando lo fa dipinge un quadro deprimente: ogni proposta di riforma come la privatizzazione di alcune università verrebbe bloccata da sollevamenti popolari; i conflitti d’interesse sono troppo forti perché una riforma della giustizia sia credibile. Ma lascia aperto uno spiraglio d’ottimismo: l’Italia quando è alle strette sa cambiare, lo ha fatto per entrare nell’Euro, lo ha fatto con le riforme Bersani e, come lo stanno facendo ora i PIGS, quando sarà in una crisi di debito saprà farlo di nuovo.
Più sconcertante è l’idea, proposta involontariamente, che pur facendo riforme l’Italia non possa uscire dal suo torpore macroeconomico. L’Economist apre il suo report notando giustamente come alcune caratteristiche dell’economia italiana siano dovute a fattori storici antichissimi che prescindono dagli attuali assetti legislativi. A tale riguardo è molto forte l’osservazione, mostrata nel grafico qui sotto, di come la forma di governo di ogni regione nel 14esimo secolo sia un buon indicatore della loro attuale performance in termini di diverse variabili economiche e sociali. Ma l’Economist è attento a dire subito che malgrado ciò i problemi dell’Italia sono recenti e risolvibili.
Questa constatazione viene però poi più volte contraddetta. Prima quando si fa notare come i problemi di competitività non possono essere risolti finché permane un paradigma manageriale culto della piccola e media impresa. Poi facendo notare come le raccomandazioni siano un fenomeno sociale. Cambiare le norme non basta. Possono essere messi in piedi gli incentivi perché le università competano di più tra loro, ma “le regole cambiano e il comportamento rimane uguale”.
Le liberalizzazioni sono ostacolate non solo dalla spropositata influenza politica di molti ordini. Anche qui si tratta di un problema culturale, legato al rinascimento; fatto costatato dal dato da un recente sondaggio del Termometro Politico. Il 61% dei giovani italiani non abolirebbe gli ordini, nonostante ne sarebbero i principali beneficiari.
Il report sull’Italia non manca di momenti di sollievo per il lettore italiano. La globalizzazione, sia come flusso di persone che di merci, avrebbe beneficiato sia l’apparato produttivo che il consumatore italiano. Abbiamo una riserva di emigrati eccellenti i quali, una volta rientrati in Italia, potrebbero contribuire ad un rilancio nazionale. Soprattutto, la ricchezza di riforme da attuare fa sì che siamo un paese con ancora molta crescita potenziale.
Ma il nodo di fondo rimane: il nostro problema di crescita non necessita solo di riforme per essere risolto. Siamo il prodotto della nostro passato. E le riforme possono essere attuate e realmente efficaci solo se cessiamo di sentirci vittime di un determinisimo storico.